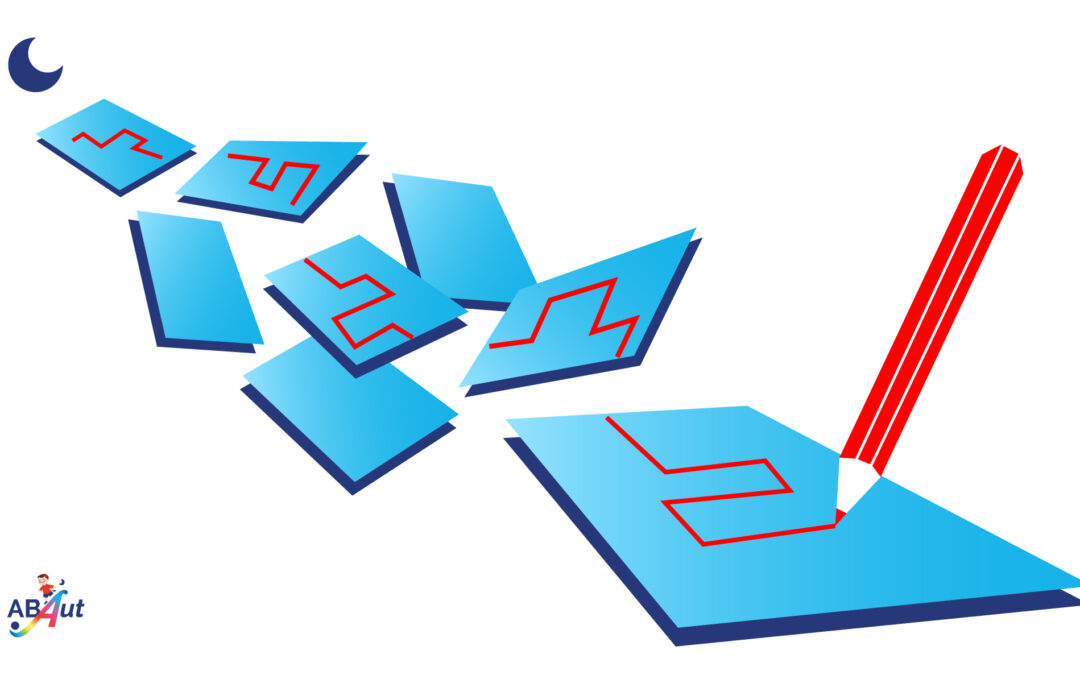Quali sono i primi passaggi burocratici che una famiglia deve affrontare dopo una diagnosi di autismo? Chi dovrebbe occuparsi di orientare i genitori in un momento così delicato? E ancora: quali ostacoli si incontrano lungo il percorso per il riconoscimento dell’invalidità civile o per l’accesso ai diritti previsti dalla Legge 104? Per rispondere a queste domande abbiamo intervistato Elisa Lovato, Analista del Comportamento certificata BCBA e IBA, pedagogista ed educatrice professionale, che ci ha aiutato a fare chiarezza sul rapporto tra diagnosi, burocrazia e tempi di attivazione delle tutele per le famiglie.
Quali sono le prime pratiche amministrative che una famiglia deve avviare dopo aver ricevuto una diagnosi di autismo?
Dopo una valutazione condotta da un servizio pubblico, come la neuropsichiatria infantile, alle famiglie viene solitamente consigliato di avviare la richiesta per il riconoscimento della Legge 104/1992, che tutela i diritti delle persone con disabilità, e dell’invalidità civile, utile per ottenere l’indennità di accompagnamento. È importante sapere che queste pratiche possono essere attivate solo a partire da una certificazione rilasciata da un ente pubblico.
Quanto tempo serve per ottenere una diagnosi?
Dipende dalla situazione. In alcuni casi, soprattutto se i segnali sono evidenti, bastano pochi incontri per arrivare a una diagnosi chiara. In altri, il percorso è più lungo: si parte da un’ipotesi diagnostica e si prosegue con una serie di osservazioni e interventi mirati. A rendere tutto più complesso è il fatto che la diagnosi di autismo si basa sull’osservazione del comportamento e non su test genetici o esami oggettivi.
Quanto tempo trascorre dal momento della diagnosi all’ottenimento di alcune indennità?
Anche qui dipende. Una volta ottenuta la certificazione, la domanda va inviata all’INPS, che convoca la famiglia per alcune visite di accertamento. In media, servono pochi mesi. Tuttavia, l’indennità ha valore retroattivo, quindi viene riconosciuta a partire dal momento della data di inoltro della richiesta. I tempi, però, variano molto da caso a caso e dipendono anche dalla capacità della famiglia di affrontare il carico emotivo e organizzativo. Ricevere e elaborare una diagnosi, non è facile. Per le famiglie straniere, il percorso è spesso ancora più ostico, perché si parte da zero: prima ancora della burocrazia, serve comprendere cos’è l’autismo, cosa aspettarsi, e cosa no, ci sono dei problemi di lingua. Ma non solo per loro, capiamo bene: nonostante si parli molto oggi di autismo rispetto al passato, si sa ancora molto poco.
Chi può aiutare concretamente i genitori in questi passaggi?
Un supporto prezioso arriva spesso dagli assistenti sociali del Comune, che possono aiutare ad affrontare la burocrazia e indirizzare verso i servizi corretti. I documenti da compilare sono tanti, i passaggi da seguire non sempre chiari, e la barriera linguistica rappresenta un ostacolo reale per molte famiglie.
Come arrivano agli interventi ABA?
L’intervento ABA non è ancora pienamente riconosciuto nel sistema sanitario pubblico, poiché non esiste un percorso universitario abilitante. Per questo motivo molte famiglie non ne sono informate, e il metodo non è, a diritto, proposto dai servizi pubblici, come è ovvio che sia. Alcuni distretti sanitari stanno iniziando a includere figure specializzate in ABA, ma ad oggi l’accesso avviene principalmente tramite percorsi privati, spesso sostenuti da bandi regionali o contributi dedicati.
Quali sono, secondo te, le principali criticità del sistema?
Oggi il problema principale non è tanto la certificazione, quanto l’accesso concreto alle terapie. I bambini con diagnosi sono sempre di più, ma i professionisti non bastano.
Un’altra grande criticità è la continuità terapeutica: nel pubblico, molti bambini vedono il proprio terapista solo saltuariamente, mentre è proprio l’intensità e la costanza dell’intervento a fare la differenza nel lungo periodo.